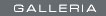Stralci di saggi critici
 1979 - Davide Lajolo – Saggista e romanziere – già direttore de “L'Unità” 1979 - Davide Lajolo – Saggista e romanziere – già direttore de “L'Unità”
 1982 - Franco Caresio – Giornalista della RAI – Studioso e scrittore d'arte 1982 - Franco Caresio – Giornalista della RAI – Studioso e scrittore d'arte
 1989 - Laura Mancinelli – Docente di letteratura alto-tedesca all'Ateneo di Torino 1989 - Laura Mancinelli – Docente di letteratura alto-tedesca all'Ateneo di Torino
 1982 - Luigi Carluccio – Critico d'Arte de “ la Gazzetta del Popolo” 1982 - Luigi Carluccio – Critico d'Arte de “ la Gazzetta del Popolo”
già direttore della “Biennale di Venezia” per le Arti Visive
 1982 - Pier Carlo Santini – Critico d'Arte – docente presso l'Università Internazionale di Firenze 1982 - Pier Carlo Santini – Critico d'Arte – docente presso l'Università Internazionale di Firenze
 1997 - Marco Rosci – Già docente di storia dell'Arte all'ateneo di Torino 1997 - Marco Rosci – Già docente di storia dell'Arte all'ateneo di Torino
Critico d'Arte a “ La Stampa ” di Torino
 1998 – Marida Faussone – Critico d'Arte 1998 – Marida Faussone – Critico d'Arte
 2003 – Nico Orengo – Romanziere e poeta – Giornalista del “ La Stampa ” di Torino 2003 – Nico Orengo – Romanziere e poeta – Giornalista del “ La Stampa ” di Torino
 2007 – Marida Faussone – Critico d'Arte
2007 – Marida Faussone – Critico d'Arte
1979 - Davide Lajolo – Saggista e romanziere – già direttore de “L'Unità”
[...] Così hai fatto un lavoro di scavo dentro te stesso, sei tornato alle radici della tua civiltà come artista e come uomo e anziché dare libero sfogo agli impulsi con un salto che sarebbe stato troppo brusco e t'avrebbe portato al dipingere dei naif, tu hai saputo indovinare e in molte tele esprimere l'anima delle cose che ci circondano. Hai cioè intrapreso un dialogo più sincero con te stesso senza lasciare zone d'ombra per arrivare ad un dialogo più intimo con la natura che ti circonda, che è quello che t'ha cresciuto nei sogni dell'infanzia, nelle aspirazioni della maturità e ti ha instillato lentamente così come il fiore nutre il nettare che giusto è il bisogno della pittura.
Così le tue tele si sono liberate da riflessi voluti e inautentici, i colori sono tornati a quelli che ti incantano giorno per giorno, le tue piante si sono aperte all'intimità della tua tenerezza, sicché realtà e sogno, verità e fantasia si sono sposate ed ora la tua pittura respira tutto l'ossigeno che solo posseggono coloro che sanno dire le cose senza grida, senza parole, voglio dire senza retorica, col meditato silenzio di chi le fa perché siano così assaporate.
Così il tuo orizzonte che parte e rientra nel ciclo della tua collina, le tue piante di ciliege e di albicocche, le tue viti che si arrampicano ai muri rossi di salnitro o gialli di verderame, si è allargato perché io vi ritrovo le mie colline, i miei alberi, il richiamo dei colori della campagna che inondano il mondo di chi li sa ancora apprezzare e perciò non hanno delimitazione di confini.
Nei tuoi ultimi quadri hai mostrato a più timidezza a presentare le figure umane.
Si comprende: perché ormai vuoi dare all'uomo, al bambino l'anima, il movimento, la vita che hai dato alle piante, alle case, alla collina. Ed è giusto.
Soprattutto come hai rivisto i tuoi colori ed i tuoi cieli, la luce, le ombre è giusto che ricollochi l'uomo naturalmente nel suo ambiente, col suo passo e i suoi pensieri.
Sei tornato te stesso, senza rifrazioni altrui, senza il timor panico di non saper rispettare le regole estetiche. Hai così ritrovato il tuo grumo di poesia, l'hai fatto germogliare col tuo fiato ed ora gli albicocchi splendono sotto il sole, le piante della collina stormiscono, la luna sta davvero alta sopra i falò, nubi e case si intendono.
| Torna su  | |
1982 - Franco Caresio – Giornalista della RAI – Studioso e scrittore d'arte
[…] quel suo tenersi appartato da scuole e correnti per una pittura limpidissima, squillante e festosa. Perché l'arte di Birolo è “Vera” reale, come è reale un prato di papaveri, un vecchio albero abbracciato dall'edera sino a soffocamento, come è reale un tramonto infuocato o un'ansa del Po in un mattino brumoso. Parlare della pittura di Birolo è facile e invitante, è come aprire una finestra su quella stessa realtà di grandi spazi sul fiume, di prati fioriti, di pergolati sommersi dal glicine. Non è necessario ricorrere a terminologie fumose, a concettualità esoteriche da iniziati.
[…] protagonista pressoché assoluta delle Sue tele è la natura affrontata con vivente certezza nella sua realtà contingente.
Una pittura fatta con tecnica rapida, di forte emozione e brillantezza, che è, insieme, percezione poetica e sottile maestria nell'uso di colori e pennelli. Le opere di Birolo, nelle loro centinaia e centinaia di vibrazioni luminose, si muovono sulla linea di un post impressionismo teso alla ricerca e alla resa di valori atmosferici, a quella che viene definita l'unità complessiva di tono. Una tecnica raffinata perché Birolo, nella ricerca della massima possibilità espressiva della gamma di accordi cromatici, di luce e colore, riscopre una specie di “puntinismo” con l'accostamento dei colori puri, non ancora mescolati nel tono voluto, in modo che l'unità di luce e colore si ricomponga nell'occhio dello spettatore. I singoli colori puri conservano quindi tutta quella brillantezza che l'impasto tradizionale rischia spesso di spegnere nelle sue impurità.
Ma è un puntinismo, quello di Birolo, che possiamo definire dinamico e vivo non di scuola, e che raggiunge virtuosismi cromatici sorprendenti.
<<Arte in Piemonte>> - RAI 2 – Torino 25 gennaio 1982
| Torna su  | |
1989 - Laura Mancinelli – Docente di letteratura alto-tedesca all'Ateneo di Torino
[…] i soggetti paesaggistici possono ancheessere sempre gli stessi, le colline che vede dalla sua casa, il melo dell'orto, la clematide rosa; ma sulla tela sono ogni volta una cosa diversa e nuova, secondo l'ora e la stagione, la luce del cielo e quella dell'anima. Il dipinto è un paesaggio dell'anima,espressione interiore, qualche volta l'idillio ritrovato, più spesso nostalgia dell'idillio, tristezza, mistero.
L'instancabile ricerca sulla luce, che in ogni quadro compare come tema centrale e di cui disegno e colore sono strumento, è elemento soggettivo, non fa parte della natura, ma della sua trasfigurazione nella mente del pittore. E il puntinismo, di cui Birolo si serve, non è solo la tecnica privilegiata che gli permette di rendere al massimo lo svariare della luce, è anche consapevolezza che la luce, come l'esistenza dell'uomo, ha un equilibrio fragile e instabile, e va conquistato giorno per giorno, opera per opera.
| Torna su  | |
1994 - Pino Mantovani – Docente di Storia dell'Arte all'Accademia di Torino
[….] nella pittura di Birolo è forse la luce l'elemento che meglio rappresenta il processo della organizzazione conoscitiva. Essa è l'accidente che frantuma l'ottusità compatta della materia restituendola sotto specie di schegge, tacche, coriandoli, molecole luminose (variamente assorbenti e riflettenti luce); e insieme il filo che ritrova drammaticamente e felicemente l'unità della materia saturando ogni interstizio, ricucendo ogni ferita, riducendo le distanze a una contiguità resa continua dalla coscienza. Luce-colore, naturalmente, cioè tono.
La coerenza di un tono definisce un'atmosfera, insieme meteorologica e sentimentale; che può permettersi d'essere espressiva di uno stato d'animo, perché si riconosce in una “natura”, in una precisa situazione, in un'ora, una stagione “naturale”.
La luce è il ponte che collega lo “spirituale” al “fisico”, lo psicologico al fisiologico, l'interiore e l'esterno. É questione di tempo, ancora. Bonnard, nei suoi taccuini annotava anche più volte nell'arco di una giornata la specie del tempo - la luce, il vento, l'umidità, gli effetti della pressione [...] - trascurando il tempo cronologico, che giorno fosse, che anno. Nel tramutare del tempo atmosferico, era sempre lo stesso giorno.
| Torna su  | |
1982 - Luigi Carluccio – Critico d'Arte de “ la Gazzetta del Popolo” – Già direttore della “Biennale di Venezia” per le Arti Visive
[…] prevalgono il disegno, il contorno, la stesura compatta della materia pittorica, l'opposizione diretta delle luci e delle ombre ad un altro stato in cui l'elemento luce, quale matrice di colore e matrice d'effetti, diventa primario. La luce ora muove la materia pittorica, la scalza, le imprime una vibrazione costante e gli dà bagliori, corposi ed intensi splendori di carattere post'impressionista, produce abbagli abbacinanti, lamelle incandescenti senza tuttavia offuscare il disegno di fondo, che appare ancora nitido, sicuro, né lo stratificarsi degli spazi prospettici, né la densa sostanza delle cose: alberi, coltivi, prati, declivi fioriti di papaveri o di ranuncoli, cancelli colmi di glicine, tetti che spiovono sotto il sole. Quel disegno di fondo, che a volte illimpidisce nella curva di una collina e che rimane il punto di riferimento del senso così vivo e profondo della realtà di natura, anzi della terra.
| Torna su  | |
1982 - Pier Carlo Santini – Critico d'Arte – docente presso l'Università Internazionale di Firenze
[...] Birolo intende l'esercizio della pittura come un completamento della vita sentimentale, o meglio come un modo di definirsi e di essere del sentimento. L'osservazione è costante, diretta e i quadri nascono sempre davanti alle cose, anche se sono completati nel raccoglimento dello studio dove certe esigenze sono più puntualmente avvertibili in un distacco anche temporale che smorza i richiami troppo immediati. Ma quell'osservare non è solo posare l'occhio sulle forme della terra, e percorrerla, e considerarla nelle variabili relazioni tra le molte componenti paesistiche viste da distanze e con angolazioni diverse. É uno scegliere secondo una personale visione; un capire le mutazioni del tempo che modificano i valori e la spazialità del paesaggio. E anche un captare i fremiti della luce trascolorante fra le nuvole nel cielo ventoso, o assorbirne le vibrazioni pulviscolari, gli aloni, le trasparenze, i contrasti. E ancora, questo osservare, è un immergersi fra le erbe e le messi, quasi un vestirsene; e respirarne i sentori e gli aromi. Ma la natura, la terra, incantatrici per tutti, sono provvide solo per i poeti.
[...] Dote peculiare di Birolo è però un vedere naturalmente equilibrato, senza sovrapposizioni schematiche o moduli fissi precostituiti. La misura compositiva è sempre diversa pur nella prevalenza delle vedute panoramiche che si concludono nell'infinito dei lontani. Cambiano le distanze, i cambi spaziali, l'emergenza dei temi di base, la quantità e la dislocazione degli episodi salienti.
Anche sul piano tecnico-esecutivo le modalità del trattamento, o, se si vuole, la gestualità sono continuamente sostenute da una vivacità che Birolo ha potuto maturare rivivendo una grande stagione pittorica, dal tempo impressionista a Bonnard. Avvicinarsi fisicamente ai quadri, per chi sappia leggere la pittura, è sempre esaltante. La condotta è schietta, rapida, sapiente, senza ombra di sofisticazione: quanto occorre per ottenere gli effetti desiderati. Il risultato è di straordinaria freschezza, con una vastissima gamma di flessioni sentimentali, dalla melanconia alla gioia, dalla tenerezza al rapimento.
Così, con levità e quasi con grazia, Alfonso Birolo ci comunica, rendendocene partecipi, la sua commozione di artista che nel cuore del ventesimo secolo ha scelto virgilianamente la natura come mezzo e fonte per realizzare la propria condizione umana.
| Torna su  | |
1997 - Marco Rosci – Già docente di storia dell'Arte all'ateneo di Torino – Critico d'Arte a “ La Stampa ” di Torino
[...] mi è parso opportuno, di fronte al fervore di luminosità cromatica e di calma, felice, lenta pulsazione e scansione spaziale di questo mondo di fiori, di campi, di variazioni del cielo nelle ore e nelle stagioni, ricordare attraverso le testimonianze che questo è un approdo, una scelta d'immagine e di emozione con un preciso significato umano, tutt'altro che “semplice e immediata”, come ha precisato la Mancinelli. Per questo lo schietto colloquio di Birolo con la naturalità – con la vita della natura e non solo con le sue forme – non è per nulla attardato o tradizionalistico, come non lo è l'adozione di un linguaggio “storico” come quello del puntinismo. In questo senso è significativo il modo del tutto personale con cui Birolo sceglie e organizza sulla tela le sue maglie e nodi del tessuto cromo-luministico più o meno fitti, con micro o minidimensioni e tocchi maggiori o minori, con maggiore scioltezza ed effusione di atmosfera tonale o ritmi più minuti e puntiformi a seconda delle diverse scelte strutturali complessive e a seconda dell'esatta, attentissima, scansione dei percorsi ottici.
[...] l'immaginazione pittorica e la pulsazione lirica di Birolo riescono a fondere questa limpida e logica scansione ottica e spaziale e l'orgoglio del pittore contadino, per sua dichiarazione, di dare forma visiva ed emozionale, di fronte alla spalliera di glicini, al campo di papaveri, alla fioritura dei meli, alla propria esperienza e scienza di floricoltore e di agronomo. Poi, di colpo, uno spettacolo celeste, un ultimo trionfo di luce al tramonto, la freschezza dell'arcobaleno dopo il temporale si sublimano in fantasia pittorica, danno una forma d'oggi all'eccitazione del “sublime” illuministico e romantico. E sia lode allora a questo felice anacronismo – l'unico per cui il termine mi suona positivo – che profuma, sensitivamente profuma di David Friedrich e di Pellizza da Volpedo.
| Torna su  | |
1998 – Marida Faussone – Critico d'Arte
[...] è dunque il misurarsi, giorno dopo giorno, con la percezione della calma luce di S. Sebastiano Po, il distillarne i filtri di tono per svelarne la minuta granitura sulla tela e lasciarla vaporare ai moti di un'atmosfera che muta, impercettibilmente, in incidenza e tersità, le effrazioni di luce ( “Il sorgere del sole”; “Motivo invernale con neve” ).
Tuttavia il mistero di un'esistenza arcana, di una linfa segreta che pulsa nei verdi vegetali, negli ocra delle terre ed esala ai grigi orizzonti, ancora riemerge in partiture di enigmatici stupori (“Sottobosco misterioso”). Lo stesso avventurarsi lungo i verdi muschi de “La rocca” o il silente indugiare nell'incanto specchiante dell'immaginario ( “L'isola Eden”; “Filemone e Bauci” ) suggeriscono in Birolo l'approdo ad un naturalismo fantastico, nitido e pacatamente indagato nella lirica sobrietà del quotidiano.
| Torna su  | |
2003 – Nico Orengo – Romanziere e poeta – Giornalista del “ La Stampa ” di Torino
[...] guardando, da anni, i quadri di Birolo Alfonso, fatti di querce e salici, faggi e ulivi, di cascate di glicini e papaveri e grano, non si può non rimanere stupefatti da un'idea di paesaggio che arriva dall'emozione del colore: un colore che continua ad essere vivo, fresco, perché colpito da una luce pensata, sapientemente calcolata, vista. Ecco allora che a darti l'emozione che passa attraverso la “finezza” o “l'idea” è la sapienza dell'artista, la capacità, come avviene in Birolo di filtrare innanzitutto le tante possibilità di vedere un luogo, per poi restituirlo, a chi guarda con l'incanto lucente dell'immediatezza.
Ma ogni metro di pianura, ogni morbidità di collina, ogni asprezza di tronco, ogni, direi foglia di fiore o di albero, in Birolo ha un nome, un corrispettivo. Si può camminare nei luoghi di Birolo come nella sua pittura, c'è un aderenza, una fedeltà che è totale. E proprio questa identificazione così precisa diventa lo scatto che trasforma la sua pittura in qualcosa che è altro, che è di più. Di fronte ai quadri di questo artista, così volutamente tradizionale e così decisamente libero e moderno, non si può che cogliere la gioia del colore e della natura, la vertigine allegra di chi sta guardando il miracolo delle stagioni, l'emblema della forma, l'assoluto delle forme primarie, che siano uno stelo, un fiore, un ramo, il getto d'acqua, la calma assolata di una pozza. Birolo, da pittore entomologo, cerca il particolare dal quale i nostri sensi possano risalire all'insieme, all'archetipo di ciò che chiamiamo albero, fiore, collina, cielo, nuvole. E la sua pittura vive così di una leggerezza che si contrappone al “peso” dei volumi, della materia trattata, con una forza che diventa suono. Si, le tele di Birolo emanano suoni: basta guardare le sue grandi nuvole appese al cielo o quegli alberi piegati da una gran generosità di fiori per sentire fischi di vento e di uccelli. É la capacità, ancora di “tradurre sentimento”, come diceva Baudelaire. Un'emozione che sconfina dalla tela per imprimersi con festosa eleganza nell'immaginazione.
| Torna su  | |
2007 - Marida Faussone - Critico d'Arte
…la sua vocazione precoce si consolida con
l'esercizio tenace a costruire solide trame pittoriche, come fa il contadino
probo e accorto, anche se gli studi universitari presso il Politecnico
torinese e l'inclinazione estetica al naturalismo ottocentesco piemontese
e lombardo imprimono al tessuto tonale venature surreali e suggestioni
metafisiche. Il linguaggio si fa analitico, solo apparentemente aderente
alla veridicità, poiché rielaborato dalla mente.
Il voluttuoso biocco di nuvola, che accompagna il viandante lungo l'erta
collinare, è certo un lembo di quei cirri capricciosi, enfiati dal vento
di San Sebastiano Po, ma, aben guardare, si fa simulacro effimero alla
nostra aspirazione, intangibile e caduca, come l'umana sorte. Allora,
così indagando, l'allusivo presagio celato nell'oscura corsa del trenino
sulla piana innevata di Chiasso o le metamorfiche strutture del ciclo
dedicato agli "alberi" o, ancora, l'approdo segreto all'improbabile
Atlantide nella sequenza delle "isole" svelano, ogni volta,
il lucido intimismo e lo sguardo ironico dell'artista che sa discernere
l'essenza dalla scorza delle cose.
Le stagioni si susseguono sulla tela, come le composizioni in interno
si configurano, nel tempo, più complesse, ma sobrie: vegetali ed oggetti
si dispongono secondo un ordine segnino rigoroso, a tratti interrotto
da volumetrie piene ed ornate, ma la tessitura timbrica è salda e pulita,
quasi ad arginare ogni indugio formale. Si osservi la trama, calma e
severa, delle gamme ablescenti, dei lini candidi, delle pagine di giornale,
del fascio di spighe, su cui la luce naturale dischiude il suo canto,
distillando preziose rifrazioni, vivide e terse, ma variegate di inattesi
lucori.
| Torna su  | |
|